H come Hitler
Il volume di Johann Lerchenwald non sembra volersi orientare a quel massimo biografo di Adolf Hitler che fu Joachim Fest con la sua monumentale biografia e neppure alla Verfilmung che ne derivò (Hitler – Eine Karriere), bensì – e non solo a prima vista, probabilmente per moda editoriale attualissima – a quella insolita nuova forma di biografia che è quella inaugurata da Antonio Scurati con la sua straordinaria opera, che attende di divenire trilogia, intitolata “M”, e qui ne sia prova proprio l’uso della lettera iniziale del nome.
Ma non basta. L’approccio è infatti dei più costitutivi nell’affrontare figura e sviluppo di uno dei più grandi mostri dell’umanità e l’originalità sta proprio nell’approccio annunciato, che non risponde appunto al canone di “come i tedeschi vedevano”, bensì come H. “vedeva” i tedeschi – che per aggiunta divengono qui, come il titolo recita, i “suoi tedeschi” – trattandosi dunque di ben altra cosa. Il procedere di questa analisi è affrontato quindi da una prospettiva prettamente soggettiva e se il libro – che l’autore si preoccupa in sottotitolo di definire curiosamente “romanzo” – non giunge ad un discorso in prima persona, a questo si avvicina molto, non foss’altro perché il lettore vede crescere il suo “eroe” in una progressione da Bildungsroman, o meglio sarebbe dire da Schelmenroman, vista la caratura di chi vi occupa il posto di protagonista. Qui basti dire che l’eroe che diverrà eponimo di un’epoca di terrore come mai viste prima sulla faccia della terra (con buona pace di Nolte) è colto dai primi momenti della sua carriera di pittore senza ventura a Vienna, di caporale nella prima Guerra, passando per i primi movimentismi delle birrerie monacensi degli anni ’20. Siamo lontani dallo straordinario diorama offerto da Scurati con i suoi primi due volumi, che hanno saputo offrire un quadro di straordinaria perizia di ciò che fu il fascismo dalla fondazione dei fasci di combattimento milanesi dei tardi anni Dieci (da cui – quasi letteralmente tradotte e per emulazione storica – derivarono appunto le famigerate Sturm-Abteilungen del primo nazional-socialismo, fino alla presa del potere e alla sua tragica consunzione.
No, Lerchenwald non riesce a far tanto, dunque a proporre una visione tanto ampia quanto riesce a fare Scurati (che occupa evidentemente una mole di pagine ben maggiore), che nei suoi Uomini del secolo e della provvidenza ci ha offerto un Berlin Alexanderplatz italiano, per ampiezza dei temi, dedizione dell'esposizione (sia essa - l'esposizione - dannunziana ovvero mussoliniana, che Scurati interpreta con immedesimazione assoluta, nella prosa e nello stile, finanche inserendo accanto alle date la numerazione dell'Era Fascista) di un’intera epoca e di una nazione che del fascismo non fu solo primo realizzatore, ma inventore tout court.
Lerchenwald, pur volendo supporre intenti più ambiziosi, riesce a fare qualcosa di più modesto ma al contempo degno, rendendoci non certo l’aura di un’intera nazione, ovvero lo spaccato di un’epoca, ma perlomeno l’ambiente di una Vienna e di una Monaco degli anni del movimentismo tedesco. Si assapora il clima di quella che fu la repubblica dei Consigli monacense (la bayerische Räterepublik, se non prima, almeno seconda repubblica ‘sovietica’, emula di quella bolscevica), si leggono i nomi dei grandi protagonisti di quel momento cruciale e negletto della storia tedesca: Toller, Landauer, Mühsam, Eisner fino al Lenin tedesco, Eugen Levine. Per certi momenti sembra di trovarsi nel dramma brechtiano Tamburi nella notte, ma poi si viene presto riportati in più lugubri cantine e birrerie, ove si praticano congiure e si scorge il “mostro” di Braunau crescere nei piccoli gruppetti destrorsi nella sua ‘resistibile’ ascesa dando vita al più grande enigma della storia dell’umanità, cioè come poté la patria di Kant e Hegel seguire fino al baratro più tremendo un caporale austriaco. Qui sta il merito, ma anche il limite del libro, che non osa dirsi biografia, tantomeno libro di storia, bensì ‘romanzo’ e non ci offre per nulla uno spaccato di un’epoca, ma semmai uno dell’encefalo di quel semplice e ben poco talentuoso homo linziano che riuscì nel giro di una dozzina di anni – sorprendendo se stesso – a porsi incredibilmente a capo di un popolo per altri terribili dodici. Tutta la tragedia è dunque contenuta in maniera pressoché matematica in questo doppio dodicennio.
Il libro ha tuttavia, rispetto all’edizione tedesca, un pregio indubitabile (che compensa semmai una traduzione a volte incerta, di cui probabilmente pochi lettori si accorgeranno), ed esso consiste nella presentazione posta a premessa a firma del prestigioso storico Franco Cardini. Lo storico esordisce nella sua presentazione, facendo suo il giudizio di Maria Teresa Iudica del libro “enigmatico e serenamente terribile”, per poi – riguardo all’indagine storica e alla ricostruzione della Storia medesima – rifarsi all’adagio pilatesco “quid est Veritas?”, che lascia sinceramente un po’ smarriti. Noi, molto modestamente, non crediamo che su questo punto vi possano essere dubbi e il Tribunale della Storia lo invochiamo davvero, ma lasciamo volentieri a Cardini il suo punto di vista. Pur senza voler scomodare lo Historikerstreit di infausta memoria (“a Nolte” tornano…), giustamente più avanti lo storico ammette: “Vi sono pur pochissimi ed eccezionali argomenti nei confronti dei quali le armi della critica debbono tacere”. Condividiamo!
Condividiamo anche quanto attesta Cardini riguardo all’autore, là dove afferma che l’approccio di Lerchenwald “non è quello storico” (p. 12), meno quando asserisce che egli ci restituirebbe un Hitler “umanamente comprensibile”. Ed è pur vero, tuttavia, che uno dei meccanismi – non l’unico, né il più solido e convincente – della Vergangenheitsbewältigung post 1945 è stato quello di addossare la responsabilità della tragedia del Terzo Reich ad una banda di farabutti “nella fallace speranza di discolparsi di fronte al mondo” (ivi). Ma non ci risulta che i tedeschi abbiano fatto solo questo, e la Schuldfrage è cosa certamente più seria. Certo che però l’”aura demoniaca”, di cui Lerchenwald ci descrive la preparazione lenta e minuziosa attorno al personaggio Hitler sia stata utile, diremmo necessaria, ad accrescerne la fama, l’autorità, il culto, aura che precede e esige quel distacco dell’uomo solo al comando, la esaltata e indispensabile solitudine che unì nei destini ancora una volta il Führer al Duce (scopriremo che anche i disturbi gastrici di entrambi – qui: “Lo stomaco era in subbuglio, l’alito pessimo”, p. 203, annotati con cura da Lerchenwald e da Scurati, aprono un altro varco in tal senso). C’è davvero da pensare al film di Helmut Dietl del 1992: Schtonk!
A noi pare tuttavia alla fine della lettura che il “mostro” non venga per nulla “ridimensionato” agli occhi del lettore e nulla giustifica il pensiero che sulla Germania di oggi una qualsiasi “luce sinistra” (p. 13) venga gettata, anche se a dirlo è lo storico Cardini (“malgrado i suoi successi economici e sociali” [della Germania], ipse dixit). Anche questa asserzione ci lascia perplessi, ma tant’è…
In un punto la presentazione di Cardini è insuperabile e va a suo merito l’aver rilevato e messo in giusta evidenza un dato, non storico – attenzione - ma stilistico che contraddistingue il libro di Lerchenwald: l’uso di una terza persona come la definisce Cardini con l’alto esempio dei Commentarii latini, “iper-autobiografica e autoapologetica” (p. 15). Il meccanismo (e non è detto che sia il risultato) è quindi “pseudo-autobiografico” con tutti i limiti e i rischi di una tale operazione, cioè di una ‘visita’ psicologica dall’interno dell’eroe (quindi tutt’altro - come già detto - di un libro-romanzo e meno ancora di un procedimento che ci permetta di comprendere come H. “vedeva i suoi tedeschi”).
Il paragone con Stalin è un’altra caduta di stile di Cardini (e ciò sì getta un’ombra) e l’immagine con cui descrive Hitler accarezzare i ragazzini della Hitlerjugend dinnanzi al bunker, nella sua ultima ora, non ci sembra altrettanto convincente di quanto invece riferisce Wolf Lepenies nel suo memorabile La seduzione della cultura nella storia tedesca, dove si narra di come il Führer avesse immaginato di prendere prigioniero Churchill e lasciarlo per il resto dei suoi giorni dipingere in una cella di prigione per amore dell’arte che con lui condivideva. Ma lasciamo questi temi!
L’autoanalisi che ci offre Lerchenwald grazie ad un approccio stilistico siffatto, compiuta - come afferma Cardini – con “l’occhio freddo e insensibile dello scienziato evoluzionista” su un tavolo di obitorio alla Monsieur le vivisecteur di musiliana memoria, ovvero di una Morgue alla Gottfried Benn, è quanto di più vivido possa esserci ed è certo il merito precipuo del libro, che però si estingue nel rapido giro di poche pagine.
Ma veniamo appunto al libro: va subito detto che dopo la lettura delle 240 pagine si percepisce agevolmente che la promessa contenuta in copertina non è mantenuta; infatti l’opera, che procede per brevi e rapidi capitoli (ben trentotto), mai giunge a farci scorgere un’analisi o uno studio di come davvero H. vedesse i “suoi” tedeschi e dove a ciò si avvicina maggiormente, questo avviene per singoli soggetti, personalità – storiche o a volte dietro l’ombra di qualche alter ego – che hanno accompagnato il protagonista del libro e resa possibile la sua incredibile e rapida ascesa, ma ciò non vale di certo per tutti i tedeschi! A questo scopo dovremo sempre – e ancor più oggi – affidarci alle sagaci ‘letture’ di un Norbert Elias e di un Canetti, o anche alle trasposizioni, per quanto di certo di parte, di un Brecht.
Una prima e pressoché unica traccia di questo procedere che avrebbe dovuto divenire metodo di analisi lo troviamo a p. 194, laddove l’autore afferma:
Ma non basta. L’approccio è infatti dei più costitutivi nell’affrontare figura e sviluppo di uno dei più grandi mostri dell’umanità e l’originalità sta proprio nell’approccio annunciato, che non risponde appunto al canone di “come i tedeschi vedevano”, bensì come H. “vedeva” i tedeschi – che per aggiunta divengono qui, come il titolo recita, i “suoi tedeschi” – trattandosi dunque di ben altra cosa. Il procedere di questa analisi è affrontato quindi da una prospettiva prettamente soggettiva e se il libro – che l’autore si preoccupa in sottotitolo di definire curiosamente “romanzo” – non giunge ad un discorso in prima persona, a questo si avvicina molto, non foss’altro perché il lettore vede crescere il suo “eroe” in una progressione da Bildungsroman, o meglio sarebbe dire da Schelmenroman, vista la caratura di chi vi occupa il posto di protagonista. Qui basti dire che l’eroe che diverrà eponimo di un’epoca di terrore come mai viste prima sulla faccia della terra (con buona pace di Nolte) è colto dai primi momenti della sua carriera di pittore senza ventura a Vienna, di caporale nella prima Guerra, passando per i primi movimentismi delle birrerie monacensi degli anni ’20. Siamo lontani dallo straordinario diorama offerto da Scurati con i suoi primi due volumi, che hanno saputo offrire un quadro di straordinaria perizia di ciò che fu il fascismo dalla fondazione dei fasci di combattimento milanesi dei tardi anni Dieci (da cui – quasi letteralmente tradotte e per emulazione storica – derivarono appunto le famigerate Sturm-Abteilungen del primo nazional-socialismo, fino alla presa del potere e alla sua tragica consunzione.
No, Lerchenwald non riesce a far tanto, dunque a proporre una visione tanto ampia quanto riesce a fare Scurati (che occupa evidentemente una mole di pagine ben maggiore), che nei suoi Uomini del secolo e della provvidenza ci ha offerto un Berlin Alexanderplatz italiano, per ampiezza dei temi, dedizione dell'esposizione (sia essa - l'esposizione - dannunziana ovvero mussoliniana, che Scurati interpreta con immedesimazione assoluta, nella prosa e nello stile, finanche inserendo accanto alle date la numerazione dell'Era Fascista) di un’intera epoca e di una nazione che del fascismo non fu solo primo realizzatore, ma inventore tout court.
Lerchenwald, pur volendo supporre intenti più ambiziosi, riesce a fare qualcosa di più modesto ma al contempo degno, rendendoci non certo l’aura di un’intera nazione, ovvero lo spaccato di un’epoca, ma perlomeno l’ambiente di una Vienna e di una Monaco degli anni del movimentismo tedesco. Si assapora il clima di quella che fu la repubblica dei Consigli monacense (la bayerische Räterepublik, se non prima, almeno seconda repubblica ‘sovietica’, emula di quella bolscevica), si leggono i nomi dei grandi protagonisti di quel momento cruciale e negletto della storia tedesca: Toller, Landauer, Mühsam, Eisner fino al Lenin tedesco, Eugen Levine. Per certi momenti sembra di trovarsi nel dramma brechtiano Tamburi nella notte, ma poi si viene presto riportati in più lugubri cantine e birrerie, ove si praticano congiure e si scorge il “mostro” di Braunau crescere nei piccoli gruppetti destrorsi nella sua ‘resistibile’ ascesa dando vita al più grande enigma della storia dell’umanità, cioè come poté la patria di Kant e Hegel seguire fino al baratro più tremendo un caporale austriaco. Qui sta il merito, ma anche il limite del libro, che non osa dirsi biografia, tantomeno libro di storia, bensì ‘romanzo’ e non ci offre per nulla uno spaccato di un’epoca, ma semmai uno dell’encefalo di quel semplice e ben poco talentuoso homo linziano che riuscì nel giro di una dozzina di anni – sorprendendo se stesso – a porsi incredibilmente a capo di un popolo per altri terribili dodici. Tutta la tragedia è dunque contenuta in maniera pressoché matematica in questo doppio dodicennio.
Il libro ha tuttavia, rispetto all’edizione tedesca, un pregio indubitabile (che compensa semmai una traduzione a volte incerta, di cui probabilmente pochi lettori si accorgeranno), ed esso consiste nella presentazione posta a premessa a firma del prestigioso storico Franco Cardini. Lo storico esordisce nella sua presentazione, facendo suo il giudizio di Maria Teresa Iudica del libro “enigmatico e serenamente terribile”, per poi – riguardo all’indagine storica e alla ricostruzione della Storia medesima – rifarsi all’adagio pilatesco “quid est Veritas?”, che lascia sinceramente un po’ smarriti. Noi, molto modestamente, non crediamo che su questo punto vi possano essere dubbi e il Tribunale della Storia lo invochiamo davvero, ma lasciamo volentieri a Cardini il suo punto di vista. Pur senza voler scomodare lo Historikerstreit di infausta memoria (“a Nolte” tornano…), giustamente più avanti lo storico ammette: “Vi sono pur pochissimi ed eccezionali argomenti nei confronti dei quali le armi della critica debbono tacere”. Condividiamo!
Condividiamo anche quanto attesta Cardini riguardo all’autore, là dove afferma che l’approccio di Lerchenwald “non è quello storico” (p. 12), meno quando asserisce che egli ci restituirebbe un Hitler “umanamente comprensibile”. Ed è pur vero, tuttavia, che uno dei meccanismi – non l’unico, né il più solido e convincente – della Vergangenheitsbewältigung post 1945 è stato quello di addossare la responsabilità della tragedia del Terzo Reich ad una banda di farabutti “nella fallace speranza di discolparsi di fronte al mondo” (ivi). Ma non ci risulta che i tedeschi abbiano fatto solo questo, e la Schuldfrage è cosa certamente più seria. Certo che però l’”aura demoniaca”, di cui Lerchenwald ci descrive la preparazione lenta e minuziosa attorno al personaggio Hitler sia stata utile, diremmo necessaria, ad accrescerne la fama, l’autorità, il culto, aura che precede e esige quel distacco dell’uomo solo al comando, la esaltata e indispensabile solitudine che unì nei destini ancora una volta il Führer al Duce (scopriremo che anche i disturbi gastrici di entrambi – qui: “Lo stomaco era in subbuglio, l’alito pessimo”, p. 203, annotati con cura da Lerchenwald e da Scurati, aprono un altro varco in tal senso). C’è davvero da pensare al film di Helmut Dietl del 1992: Schtonk!
A noi pare tuttavia alla fine della lettura che il “mostro” non venga per nulla “ridimensionato” agli occhi del lettore e nulla giustifica il pensiero che sulla Germania di oggi una qualsiasi “luce sinistra” (p. 13) venga gettata, anche se a dirlo è lo storico Cardini (“malgrado i suoi successi economici e sociali” [della Germania], ipse dixit). Anche questa asserzione ci lascia perplessi, ma tant’è…
In un punto la presentazione di Cardini è insuperabile e va a suo merito l’aver rilevato e messo in giusta evidenza un dato, non storico – attenzione - ma stilistico che contraddistingue il libro di Lerchenwald: l’uso di una terza persona come la definisce Cardini con l’alto esempio dei Commentarii latini, “iper-autobiografica e autoapologetica” (p. 15). Il meccanismo (e non è detto che sia il risultato) è quindi “pseudo-autobiografico” con tutti i limiti e i rischi di una tale operazione, cioè di una ‘visita’ psicologica dall’interno dell’eroe (quindi tutt’altro - come già detto - di un libro-romanzo e meno ancora di un procedimento che ci permetta di comprendere come H. “vedeva i suoi tedeschi”).
Il paragone con Stalin è un’altra caduta di stile di Cardini (e ciò sì getta un’ombra) e l’immagine con cui descrive Hitler accarezzare i ragazzini della Hitlerjugend dinnanzi al bunker, nella sua ultima ora, non ci sembra altrettanto convincente di quanto invece riferisce Wolf Lepenies nel suo memorabile La seduzione della cultura nella storia tedesca, dove si narra di come il Führer avesse immaginato di prendere prigioniero Churchill e lasciarlo per il resto dei suoi giorni dipingere in una cella di prigione per amore dell’arte che con lui condivideva. Ma lasciamo questi temi!
L’autoanalisi che ci offre Lerchenwald grazie ad un approccio stilistico siffatto, compiuta - come afferma Cardini – con “l’occhio freddo e insensibile dello scienziato evoluzionista” su un tavolo di obitorio alla Monsieur le vivisecteur di musiliana memoria, ovvero di una Morgue alla Gottfried Benn, è quanto di più vivido possa esserci ed è certo il merito precipuo del libro, che però si estingue nel rapido giro di poche pagine.
Ma veniamo appunto al libro: va subito detto che dopo la lettura delle 240 pagine si percepisce agevolmente che la promessa contenuta in copertina non è mantenuta; infatti l’opera, che procede per brevi e rapidi capitoli (ben trentotto), mai giunge a farci scorgere un’analisi o uno studio di come davvero H. vedesse i “suoi” tedeschi e dove a ciò si avvicina maggiormente, questo avviene per singoli soggetti, personalità – storiche o a volte dietro l’ombra di qualche alter ego – che hanno accompagnato il protagonista del libro e resa possibile la sua incredibile e rapida ascesa, ma ciò non vale di certo per tutti i tedeschi! A questo scopo dovremo sempre – e ancor più oggi – affidarci alle sagaci ‘letture’ di un Norbert Elias e di un Canetti, o anche alle trasposizioni, per quanto di certo di parte, di un Brecht.
Una prima e pressoché unica traccia di questo procedere che avrebbe dovuto divenire metodo di analisi lo troviamo a p. 194, laddove l’autore afferma:
Il presupposto primo e imprescindibile per la riuscita dei suoi piani erano stati comunque i Tedeschi [che il traduttore si ostina a scrivere in maiuscolo, NdA], senza i quali il sogno di tribuno acclamato dalle masse sarebbe restato pura fantasticheria.La chiave di questo dilemma la troviamo molto (troppo) avanti nel libro, a p. 231, laddove “lui” (così è chiamato lungo tutto il volume) afferma, o meglio pensa (lo stream of consciousness è d’obbligo):
Tuttavia rimasto di nuovo solo, poteva succedere che si mettesse a riflettere su quella che sarebbe stata la sorte dei Tedeschi in caso di sconfitta. Li vedeva maledetti e marchiati agli occhi del mondo intero, per i secoli dei secoli. E poiché, malgrado tutte le menzogne e la mancanza di scrupoli, aveva sviluppato per loro, negli anni, una specie d’affetto paterno, in quei momenti veniva sopraffatto da qualcosa di simile alla vergogna e al senso di colpa.Si rivela quindi alla fine qua l’ipotetico senso di vergogna e di colpa di H.: non verso le mostruosità compiute o fatte compiere in suo nome, bensì verso il “suo” popolo, un giorno visto come ‘maledetto’.
E qui forse vale la pena fare qualche passo indietro e individuare segni premonitori di quella ‘maturazione’ cui il futuro dittatore giunge, individuata per mezzo del procedimento stilistico inventato dall’autore. A p. 54 infatti egli afferma:
Portatovi da frasi di ufficiali captate qua e là, ma anche da certe letture fatte, cominciò a inquadrare l’entrata in guerra della Germania in un contesto più ampio. Questa non era stata determinata in primo luogo dalla cosiddetta fedeltà nibelungica, ma da precise rivendicazioni politiche ed economiche.
Oppure a p. 60, dove si legge a proposito dello spiantato caporale, in licenza a Monaco:
E, per la prima volta da quando si trovava in Germania, sentì parlare degli Ebrei come di speculatori e profittatori di guerra.
La sua maturazione la si coglie passo a passo, così a p. 83:
Nella classe dominante della Vienna imperiale , l’avversione per i socialisti e gli Ebrei era di moda […] Le cose andavano diversamente in Germania,
affermazioni dunque che ci descrivono l’ ‘apprendistato’ del pittore di cartoline, con il suo sovversivo ardore, compreso l’avvicinamento alla Società Thule e poi al resto.
Le numerose allusioni a continui “passi falsi” (vedi p. 123: riferimento al rapporto incestuoso con una congiunta, e al successivo suicidio della stessa?) nella fortunosa carriera del futuro Führer rimangono spesso enigmatiche nell’economia del libro o non chiarite al lettore, come d’altronde ugualmente numerosi sono i riferimenti all’idea di suicidio, che si avvererà poi alla fine. Precisi sono i riferimenti alle agitazioni monacensi di quell’epoca e il ragguaglio a quello che doveva essere il culmine della depressione del caporale austriaco, la sua restrizione nella fortezza di Landsberg, che viene giustamente valutata invece come il culmine e la svolta della spietata carriera. Diremmo che quelle centrali sono le pagine più intense dell’intero libro, le più strutturate e meglio evocative dell’epoca e del personaggio, dopodiché il ritmo cala vertiginosamente e tutto procede per passaggi fin troppo repentini, poco allusivi e neppure simbolici (a p. 137 ci troviamo già di fronte a Ludendorff e alle prime elezioni della NSDAP).
Andando per tali veloci passi, si giunge alla descrizione della Gleichschaltung del sistema, in cui nella descrizione della vita quotidiana della Germania hitleriana e del suo dittatore sembra di vedere all’opera Charlot nel suo Grande dittatore.
L’ultimo capitolo lascia sinceramente interdetti, dibattuto com’è fra ironia e cinismo (categorie qui difficilmente districabili l’una dall’altra) finisce per far relegare l’intero libro a nostro avviso nella difficoltosa e contraddittoria categoria della letteratura d’evasione – tradendo così anche la definizione di “romanzo” che l’autore ha voluto affibbiargli.
Le numerose allusioni a continui “passi falsi” (vedi p. 123: riferimento al rapporto incestuoso con una congiunta, e al successivo suicidio della stessa?) nella fortunosa carriera del futuro Führer rimangono spesso enigmatiche nell’economia del libro o non chiarite al lettore, come d’altronde ugualmente numerosi sono i riferimenti all’idea di suicidio, che si avvererà poi alla fine. Precisi sono i riferimenti alle agitazioni monacensi di quell’epoca e il ragguaglio a quello che doveva essere il culmine della depressione del caporale austriaco, la sua restrizione nella fortezza di Landsberg, che viene giustamente valutata invece come il culmine e la svolta della spietata carriera. Diremmo che quelle centrali sono le pagine più intense dell’intero libro, le più strutturate e meglio evocative dell’epoca e del personaggio, dopodiché il ritmo cala vertiginosamente e tutto procede per passaggi fin troppo repentini, poco allusivi e neppure simbolici (a p. 137 ci troviamo già di fronte a Ludendorff e alle prime elezioni della NSDAP).
Andando per tali veloci passi, si giunge alla descrizione della Gleichschaltung del sistema, in cui nella descrizione della vita quotidiana della Germania hitleriana e del suo dittatore sembra di vedere all’opera Charlot nel suo Grande dittatore.
L’ultimo capitolo lascia sinceramente interdetti, dibattuto com’è fra ironia e cinismo (categorie qui difficilmente districabili l’una dall’altra) finisce per far relegare l’intero libro a nostro avviso nella difficoltosa e contraddittoria categoria della letteratura d’evasione – tradendo così anche la definizione di “romanzo” che l’autore ha voluto affibbiargli.
Luca Renzi


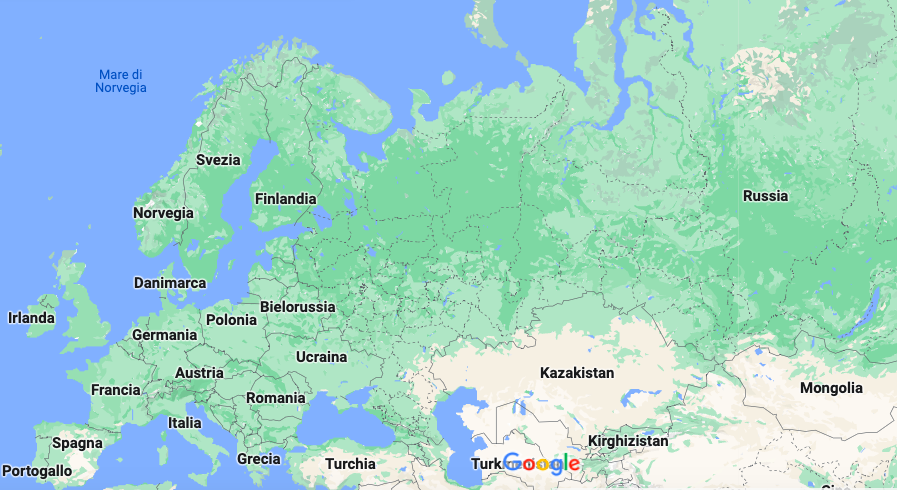

Commenti
Posta un commento